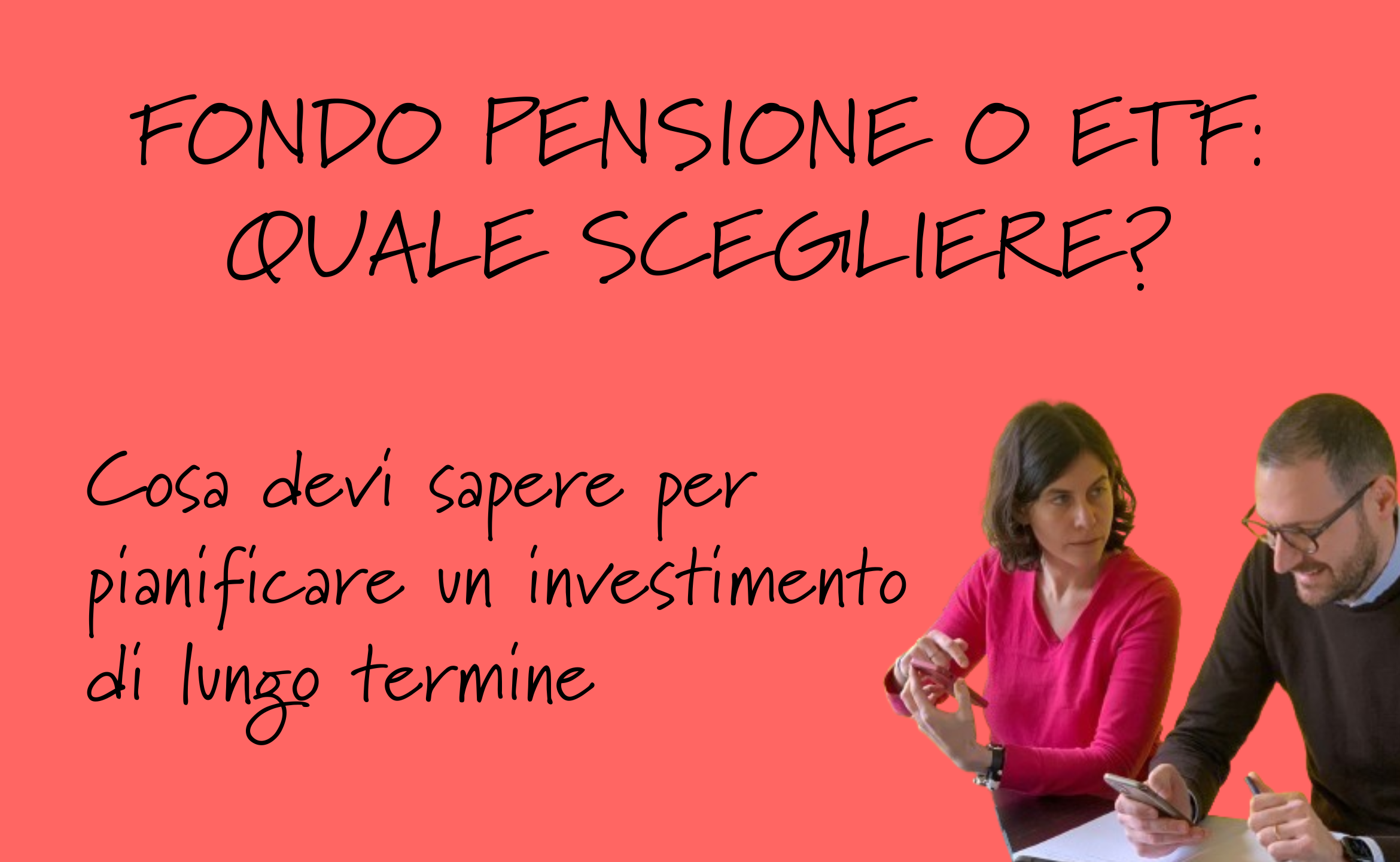
Ciao Elsa è una startup innovativa nata con l’obiettivo di rendere semplici e comprensibili temi che solitamente appaiono complessi o noiosi, come la previdenza, il TFR e i fondi pensione.
Proprio per questo, nel tempo, ci è stato chiesto spesso: conviene di più investire in un fondo pensione oppure costruire un piano di accumulo in ETF?
La domanda è tutt’altro che banale.
Non esiste una risposta valida per tutti, perché si tratta di due strumenti con caratteristiche e finalità differenti.
Il fondo pensione nasce con la logica di integrare la pensione pubblica, offrendo importanti vantaggi fiscali e, per i lavoratori dipendenti, la possibilità di destinare anche il TFR. Va però ricordato che, essendo concepito con finalità previdenziali, il ritiro anticipato delle somme versate è soggetto a limitazioni e vincoli specifici stabiliti da una legge dello Stato Italiano: il d.Lgs 252/2005.
Gli ETF sono strumenti di mercato estremamente flessibili e a basso costo, pensati per chi desidera costruire un portafoglio personalizzato e avere la libertà di disinvestire in qualsiasi momento.
In questo articolo analizzeremo nel dettaglio le principali caratteristiche di entrambi, evidenziandone punti di forza e limiti, per comprendere meglio in quali casi possa risultare più conveniente l’uno o l’altro.
Fondo pensione e ETF: cosa sono e cosa si versa
Iniziamo il nostro approfondimento dai fondi pensione.
Essi sono strumenti di investimento pensati e strutturati con una finalità precisa: permettere a ciascun lavoratore di costruire, nel tempo, una riserva economica da utilizzare al momento della pensione.
A differenza di altri investimenti, il fondo pensione non nasce come un prodotto di puro accumulo o di crescita patrimoniale, ma come un pilastro complementare rispetto alla pensione pubblica.
Il meccanismo è semplice: chi aderisce può decidere di versare volontariamente risorse personali, con cadenza periodica oppure occasionale. A questi contributi si può aggiungere il conferimento del TFR maturando, un’opzione spesso vantaggiosa per i lavoratori dipendenti per due ragioni principali:
- una tassazione agevolata sul TFR;
- la possibilità prevista in alcuni fondi di ricevere il contributo del datore di lavoro.
Quest’ultimo è un apporto aggiuntivo a carico dell’azienda, che rappresenta a tutti gli effetti un “premio” per chi sceglie la previdenza complementare.
Diversamente, gli ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, sono strumenti finanziari scambiati nei mercati regolamentati, solitamente a gestione passiva, che negli anni hanno rivoluzionato il modo di investire grazie alla loro semplicità ed efficienza.
Si tratta di fondi che replicano l’andamento di un indice di mercato (azionario, obbligazionario, settoriale o geografico) e che possono essere acquistati e venduti in tempo reale proprio come un’azione.
Uno degli aspetti che rendono interessanti gli ETF è senza dubbio il livello dei costi.
Essendo fondi quasi sempre a gestione passiva che si limitano a replicare fedelmente l’indice di riferimento, non necessitano di team di gestori che scelgano quali titoli acquistare o vendere: questo comporta spese di gestione estremamente contenute, spesso inferiori allo 0,2% annuo, che li rendono molto competitivi rispetto ai fondi tradizionali a gestione attiva.
L’investitore può decidere liberamente quanto e quando versare, senza limiti massimi, e ha la possibilità di disinvestire in qualunque momento.
È proprio questa flessibilità a rappresentare uno dei tratti distintivi più apprezzati: non esistono vincoli temporali né condizioni particolari per accedere al capitale accumulato, anche se questo talvolta può esporre l’investitore al rischio di scelte impulsive, soprattutto nei momenti di volatilità dei mercati.
Le differenze fiscali tra i due strumenti di investimento
Iniziamo con un elemento presente in entrambi gli strumenti: la tassazione sui rendimenti ottenuti (detti plusvalenze).
Le plusvalenze generate dagli ETF sono tassate al momento della vendita al:
- 26% sui risultati conseguiti da titoli privati (azioni, obbligazioni societarie, ecc)
- 12,5% sugli interessi dei Titoli di Stato italiano e di quelli rientranti nella cosiddetta “White List” (elenco di paesi considerati “collaborativi” dal punto di vista fiscale, in quanto garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia).
Il fatto che le plusvalenze ottenute con un ETF vengano tassate solo al momento della liquidazione, comporta che il meccanismo dell’interesse composto funzioni in maniera “piena” fin quando non si decide, eventualmente, di disinvestire.
Nei fondi pensione il funzionamento fiscale segue una logica differente rispetto ad altri strumenti di investimento. La tassazione sulle plusvalenze maturate viene applicata ogni anno, a prescindere dal fatto che l’iscritto richieda o meno una prestazione o della liquidità.
Questo meccanismo riduce in parte l’effetto interesse composto e quindi la crescita del capitale nel lungo periodo. Tale limite, tuttavia, è in parte bilanciato dal fatto che la tassazione applicata è:
- 20% sui rendimenti conseguiti dalle forme di investimento diverse dai titoli di stato
- 12,5% sulle plusvalenze degli strumenti rientranti in “White List”.
Fatta questa precisazione, l’ETF si presenta come uno strumento sostanzialmente “neutrale” sul piano fiscale. Ciò significa che l’investitore non beneficia di agevolazioni particolari nel momento in cui effettua i versamenti e, una volta prelevato il capitale, non vi sono imposte da pagare: l’importo disponibile corrisponde a quanto accumulato al netto della sola tassazione sui guadagni realizzati.
Impostazione completamente diversa dai fondi pensione che consentono di ottenere due importanti agevolazioni:
- la deducibilità fiscale sui versamenti fino ad un massimo di € 5.164,57 annui
- tassazione finale sul TFR ridotta (max 15% - min 9%), completamente slegata dalle logiche “IRPEF” (min 23% - max 43%).
Fondi pensione e deducibilità: come funziona
Fiscalmente, il funzionamento dei fondi pensione è molto diverso da altri strumenti di risparmio: essi offrono il vantaggio della deducibilità fiscale sui versamenti fino a un massimo di 5.164,57 € all’anno.
In pratica, la deduzione ti permette di ridurre il reddito imponibile, ossia la base su cui vengono calcolate le imposte annuali.
In Italia, infatti, l’imposta sul reddito delle persone fisiche si chiama IRPEF e varia in base agli scaglioni di reddito, secondo la logica “più guadagni, maggiore è l’imposta”.

Per fare un esempio concreto:
- sui primi 28.000 € di reddito lordo l’aliquota è del 23%
- per la parte compresa tra 28.000 € e 50.000 € sale al 35%
- sui redditi superiori a 50.000 € l’aliquota è del 43% per la quota eccedente.
Se il tuo reddito annuo lordo è di 51.000 €, l’IRPEF si calcola così:
- Sui primi 28.000 € pagherai il 23%, cioè 6.440 €;
- Sui successivi 22.000 € (da 28.000 € a 50.000 €) pagherai il 35%, pari a 7.700 €;
- Sull’ultimo 1.000 € pagherai il 43%, cioè 430 €.
Il totale dell’imposta annua sarà quindi 6.440 € + 7.700 € + 430 € = 14.570 €.
Se decidi di versare dei contributi nel tuo fondo pensione, lo Stato ti “premia”: abbassa il tuo reddito imponibile, come se quei soldi non fossero mai entrati nei tuoi guadagni, riducendo così l’IRPEF dovuta.
Questo è, in sostanza, il meccanismo della deduzione fiscale per i fondi pensione: un modo concreto per risparmiare sulle tasse mentre costruisci la tua pensione futura.
Riprendendo il medesimo esempio e immaginando un versamento di 5.000 € al fondo pensione, il calcolo parte dalla “fine” ovvero dallo scaglione IRPEF più elevato:
- sui primi 1.000 € è riconosciuta la deducibilità al 43% = 430 €
- sui rimanenti 4.000 è previsto un ritorno fiscale del 35% = 1.400 €
Per un totale complessivo di 1.830 € di risparmio fiscale immediato che, volendo, potrebbe essere reinvestito nel fondo pensione o in un altro strumento finanziario, come l’ETF stesso, con l’obiettivo di creare un effetto moltiplicatore che rende la deducibilità un aspetto ancora più interessante.
Tieni presente, però, che se oggi i versamenti godono di un “sconto fiscale”, al momento del pensionamento il capitale versato sarà soggetto a tassazione, che, anticipiamo, risulta comunque conveniente.
La tassazione finale nei fondi pensione
A differenza di quanto accade normalmente, nei fondi pensione la tassazione al momento del pensionamento non dipende dal reddito che hai guadagnato, bensì dal fattore tempo.
Se apri un fondo pensione e lo chiudi entro 15 anni di iscrizione al fondo, perché sei arrivato in pensione, la tassazione che paghi sul versato è pari al 15%.
Questa stessa tassazione diminuisce dello 0,3% ogni anno successivo al quindicesimo, fino a raggiungere la tassazione minima del 9% dopo 35 anni.
Ciò significa che più a lungo si è iscritti al fondo pensione, minori saranno le tasse.
Diventa quindi fondamentale prestare attenzione a un particolare: la data di prima iscrizione alla previdenza complementare.
Aprire una posizione, anche con un versamento minimo, significa fissare la data di prima adesione e iniziare subito a maturare gli anni necessari per ottenere la minore tassazione agevolata finale. È una scelta strategica: chi apre un fondo a 30 anni, anche con pochi versamenti, potrà comunque beneficiare della tassazione più bassa possibile quando arriverà il momento della pensione.
Per questo motivo, sono sempre più numerosi i genitori che iscrivono i figli al fondo pensione fin da piccoli.
Con un singolo versamento è possibile “fissare” la data di iscrizione per loro e donare uno dei beni più preziosi: il tempo, che permette di accumulare fin da giovani una solida anzianità nella previdenza complementare.
È importante ricordare tre aspetti relativi alla data di prima iscrizione alla previdenza complementare:
- Se l’iscritto decide di cambiare fondo pensione, operazione eventualmente consentita ogni due anni, il trasferimento permette di spostare non solo il montante accumulato, ma anche gli anni di iscrizione già maturati.
- Nel caso in cui l’iscritto abbia più fondi pensione, attivati in momenti diversi, al momento del pensionamento può far valere per tutti la data di adesione più “vecchia”. Ad esempio, se il fondo A è stato aperto nel 2010 e il fondo B nel 2025, è possibile considerare per entrambi la data del 2010, avendo cura di richiedere la liquidazione del fondo A per ultimo.
- L’eventuale riscatto totale del proprio primo fondo richiesto prima del pensionamento (vedi paragrafo successivo) comporta la perdita della data di prima iscrizione: se si valutasse di re-iscriversi successivamente, non vi è modo di recuperarla e praticamente si ripartirebbe da zero nel conteggio degli di anzianità
Libertà e limiti al prelievo: vincoli o protezione?
Abbiamo anticipato come gli ETF siano strumenti estremamente liberi in quanto il lotto minimo di negoziazione per tutti gli ETF è pari ad una sola quota (è quindi possibile accedere all'investimento anche con poche decine di euro) e non ci sono limitazioni nel ritiro delle somme che può avvenire in qualsiasi momento essendo gli ETF trattati in mercati finanziari quotati e liquidi.
Diverso è il caso dei fondi pensione: i versamenti non sono obbligatori e l’iscritto può decidere liberamente quanto e quando contribuire. Tuttavia, a differenza di un ETF, le somme accumulate non sono immediatamente disponibili. La normativa prevede vincoli circoscritti all’utilizzo anticipato delle somme perché l’obiettivo dello strumento è quello di garantire un capitale o una rendita in un momento preciso: alla pensione.
Esistono tuttavia delle eccezioni.
È possibile richiedere anticipazioni; più nello specifico, richieste di anticipo per:
- spese sanitarie gravi per sé, per il coniuge e per i figli, richiedibile in qualsiasi momento;
- per l’acquisto della prima casa, per sè e per i figli, dopo 8 anni di adesione
- per altre esigenze, sempre dopo 8 anni di adesione.
La normativa prevede anche la possibilità di riscattare anticipatamente il fondo pensione, anche in forma parziale, in specifiche situazioni, come ad esempio la perdita dei requisiti minimi di partecipazione a quel fondo o lo stato di disoccupazione.
È importante sottolineare che, in alcuni casi, il riscatto del fondo prima del pensionamento non consente di usufruire della tassazione agevolata prevista al momento della pensione, ma è soggetto a una tassazione fissa del 23%. Se vuoi approfondire il tema, ecco il nostro articolo dedicato al riscatto nei fondi pensione.
Una volta raggiunta l’età pensionabile, il capitale accumulato può essere ritirato in modi diversi.
È possibile trasformarlo in una rendita che integra la pensione pubblica, ma si può anche richiedere la liquidazione in capitale, entro certi limiti stabiliti dalla normativa.
Detto questo, i fondi pensione offrono un certo grado di flessibilità, pur entro limiti ben definiti. Questi vincoli sull’utilizzo immediato non vanno visti necessariamente come uno svantaggio, ma anche come una forma di tutela.
Se l’obiettivo dell’investitore è fortemente previdenziale, avere una barriera che impedisce disinvestimenti impulsivi rappresenta una garanzia di disciplina e di protezione del risparmio destinato alla pensione.
Al contrario, strumenti come gli ETF offrono liquidità immediata, ma questa facilità può trasformarsi in una tentazione: vendere nei momenti di mercato sfavorevoli o utilizzare i soldi per spese correnti, compromettendo così l’accumulo del capitale.
Anche in questo caso, non esiste una flessibilità “giusta” o “sbagliata”: ciascun individuo deve valutare, in base ai propri obiettivi di risparmio, i vantaggi e gli svantaggi di ogni strumento.
Costi e rendimenti a confronto tra fondi pensione ed ETF
Come abbiamo detto in precedenza, dal punto di vista dei costi, gli ETF hanno pochi rivali. Con spese di gestione ridottissime, consentono di riconoscere a chi li possiede gran parte dei rendimenti generati dallo strumento.
I fondi pensione, invece, presentano una gamma di costi più variegata .
In Italia, sono infatti presenti tre “famiglie” di fondi pensione:
- FPN (Fondi Pensione Negoziali), detti anche fondi di categoria; si tratta di strumenti collettivi nati sulla base di intese condivise tra rappresentanti dei lavoratori, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e datori di lavoro.
- FPA (Fondi Pensione Aperti); come suggerisce il nome, sono fondi aperti a chiunque voglia costruirsi una pensione complementare, senza alcuna limitazione legata alla posizione professionale o al settore di appartenenza.
- PIP (Piani Individuali Pensionistici); fondi pensione ad adesione individuale, istituiti e amministrati dalle compagnie di assicurazione che, al pari dei fondi negoziali e dei fondi aperti, operano sotto la costante supervisione della COVIP.
Sotto il profilo dei costi, i fondi negoziali sono molto competitivi, con costi di gestione che in alcuni casi scendono sotto lo 0,2% o addirittura meno dello 0,1%, quindi assimilabili ai costi degli ETF.
I fondi aperti hanno costi di gestione più alti, attorno allo 0,7 - 1,50%, mentre i PIP assicurativi possono arrivare anche a più dell’1,5%, riducendo in maniera significativa la performance netta.
Quanto ai rendimenti, i dati storici mostrano differenze interessanti. Negli ultimi vent’anni, le linee di investimento azionarie dei fondi pensione hanno offerto un rendimento medio annuo netto composto intorno al 4,0% - 4,5% (dato aggiornato, Relazione Covip 2025). Se ci soffermiamo sugli ETF azionari globali, hanno reso di più, anche oltre l'8,0% - 9,0% annuo, ma con una volatilità decisamente più elevata.
Da ricordare che i rendimenti dei fondi pensione sono calcolati e pubblicati nel sito della COVIP già al netto sia dei costi di gestione sia della tassazione sulle plusvalenze, applicata annualmente (unica eccezione rappresentata dai PIP). I risultati degli ETF, pur considerando già i costi di gestione, non includono invece l’imposta finale sui rendimenti.
Il confronto puntuale è tuttavia difficile da proporre: la normativa che regola i fondi pensione, infatti, impone una certa prudenza nelle allocazioni.
Difficilmente si trovano fondi pensione interamente azionari come gli indici degli ETF, perché è previsto un bilanciamento che includa anche obbligazioni e, in alcuni casi, investimenti immobiliari. Questa scelta riduce le potenzialità di rendimento, ma garantisce una maggiore stabilità nei momenti di crisi di mercato in funzione dello scopo “previdenziale” dello strumento.
Focus: la gestione del TFR e il contributo del datore di lavoro
Merita un approfondimento a parte la questione legata alla gestione del TFR.
Ricordiamolo: il TFR corrisponde a una quota del 6,91% della retribuzione annua lorda del lavoratore, che l’azienda non corrisponde immediatamente al dipendente, ma accantona nel corso degli anni e corrisponderà tendenzialmente al termine del rapporto di lavoro.
Accertato che non è possibile farsi accreditare mensilmente il TFR in busta paga, al lavoratore restano due sole opzioni per decidere come gestirlo:
- lasciarlo in azienda (dal 2007, per le aziende con più di 50 dipendenti, è previsto l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria Inps)
- destinarlo a un fondo pensione.
Nel secondo caso, si aprono tre valutazioni importanti da prendere in considerazione:
- Tassazione finale più favorevole. Come già accennato, la tassazione finale nei fondi pensione avviene con un regime separato (dal 15% al 9%), che non considera il reddito imponibile dell’iscritto, ma si basa invece sugli anni di anzianità contributiva maturati nella previdenza complementare. In pratica, un lavoratore di 20-30 anni che oggi decidesse di destinare il TFR al fondo pensione potrebbe beneficiare, al momento della pensione, di una tassazione ridotta al 9% anche sul proprio trattamento di fine rapporto.
Diversamente, il TFR lasciato in azienda viene tassato facendo riferimento all’aliquota media IRPEF calcolata sugli ultimi cinque anni precedenti la sua liquidazione. Come abbiamo visto parlando di deduzione fiscale, le aliquote IRPEF vanno dal 23% (primo scaglione) fino al 43% (terzo scaglione).
- Rivalutazione nel tempo. Se lasciato in azienda, il TFR viene rivalutato per legge con una percentuale fissa dell’1,5% più il 75% dell’inflazione annua. Questo significa che, in periodi di alta inflazione, il tasso di rivalutazione può risultare elevato (così come l’aumento del costo della vita), mentre in periodi di bassa inflazione la crescita del TFR rimane contenuta. L’ultima Relazione Covip per l’anno 2025 ha evidenziato come negli ultimi 20 anni la rivalutazione del TFR in azienda si è assestata al 2,5% medio.
- Possibilità di ricevere un contributo aggiuntivo del datore di lavoro. Molti contratti collettivi prevedono infatti che, se il dipendente versa almeno una piccola quota di contributo volontario, l’azienda sia obbligata ad aggiungere un contributo “extra” pari a una percentuale della retribuzione (spesso tra l’1% e il 2%). In Ciao Elsa, li chiamiamo “soldi gratis” e rappresentano un vero e proprio “surplus” a cui non si ha diritto se si lascia il TFR in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.
Simulazioni e scenari possibili con un fondo pensione o un ETF
Lo diciamo subito: non esiste un vincitore assoluto.
Alcune simulazioni evidenziano come sul lunghissimo periodo (30-40 anni), un piano di accumulo in ETF tende ad avere rendimenti più elevati grazie al compounding (capacità dei rendimenti di accumularsi nel tempo) non penalizzato dalle trattenute fiscali annuali previste nei fondi pensione.
Tuttavia, se nel confronto si inserisce la deduzione fiscale il divario con i fondi pensione può annullarsi e addirittura ribaltarsi, in base a due variabili fondamentali:
- lo scaglione IRPEF che si recupera in base al proprio reddito. Ovviamente, tra recuperare il 23% di imposta o il 43% c’è una sostanziale differenza;
- l’età di riferimento. Ci spieghiamo meglio con degli esempi.
- Per un giovane di 25 anni, con molto tempo davanti e magari un reddito ancora basso, un PAC in ETF può risultare la scelta più conveniente per i suoi risparmi, soprattutto per la flessibilità e l’assenza di vincoli; potrebbe tuttavia essere sensato comunque aprire un fondo pensione con un versamento minimo per bloccare la data di adesione e, soprattutto, per destinare il TFR maturando ( se si lavora come dipendenti), iniziando a costruire i benefici fiscali futuri. Il TFR può essere versato solo in un fondo pensione come alternativa a lasciarlo in azienda.
- Già dopo i 45 o 50 anni, quando l’orizzonte temporale si accorcia e il reddito è tendenzialmente più alto, il vantaggio fiscale del fondo pensione diventa determinante grazie alla deducibilità, tanto da renderlo spesso più conveniente, soprattutto per chi ha redditi superiori a 50.000 € all’anno.
- Negli ultimi dieci anni prima della pensione, poi, la scelta del fondo pensione diventa quasi obbligata, perché l’impatto della deducibilità, al netto della tassazione finale, risulta quasi sempre super conveniente (soprattutto per chi ha aderito da giovane e ha redditi medio-alti).
Non bisogna infine dimenticare che la scelta non riguarda solo numeri e simulazioni. Ci sono aspetti pratici e psicologici che incidono in modo significativo.
Per molti lavoratori è più semplice aderire a un fondo pensione, magari per il tramite del datore di lavoro, senza dover imparare a usare piattaforme di trading o preoccuparsi di costruire un portafoglio diversificato.
Allo stesso tempo, i vincoli presenti nel fondo pensione possono essere percepiti come una protezione: sapere che i soldi non sono immediatamente disponibili aiuta a resistere alla tentazione di utilizzarli per spese superflue.
Gli ETF, al contrario, sono ideali per chi desidera costruire un percorso di accumulo autonomo, flessibile e personalizzabile, accettando però l’assenza di incentivi fiscali. Offrono libertà e controllo totale, ma questa libertà può diventare un ostacolo per chi non ha disciplina o solidi pilastri di educazione finanziaria. È importante essere consapevoli che la flessibilità, se mal gestita, rischia di trasformarsi in un punto debole.
Conclusioni: cosa conviene alla fine?
Il confronto tra fondo pensione ed ETF non può portare a un verdetto univoco che valga sempre per qualunque situazione. Si tratta di due strumenti diversi, che rispondono a esigenze differenti.
Il fondo pensione è pensato per rispondere a un futuro bisogno previdenziale e offre vantaggi fiscali e contributivi difficilmente eguagliabili, soprattutto per i lavoratori dipendenti.
Gli ETF sono strumenti di mercato efficienti e flessibili, adatti a chi vuole gestire in autonomia il proprio percorso di accumulo.
La scelta dipende inoltre da fattori personali quali l’età, il reddito, la propensione al rischio, la disciplina nell’investimento e la situazione lavorativa.
In realtà, la soluzione più efficace spesso non è scegliere uno strumento a discapito dell’altro, ma integrarli. Aprire un fondo pensione con il TFR o, se non si è lavoratori dipendenti, anche solo con un versamento minimo per bloccare la data di prima iscrizione alla previdenza complementare e iniziare a costruire le basi per i benefici fiscali futuri e, parallelamente, utilizzare gli ETF per diversificare e mantenere flessibilità.
La vera chiave sta nella consapevolezza. Conoscere a fondo le caratteristiche, i vantaggi e i limiti di ciascun prodotto permette di costruire una strategia equilibrata e sostenibile, capace di garantire serenità economica non solo durante la vita lavorativa, ma soprattutto nel momento più delicato: quello del pensionamento.
Se desideri capire meglio il funzionamento del sistema pensionistico italiano e scoprire se la previdenza complementare può fare per te, Ciao Elsa ti offre due modalità di supporto:
- Chiacchiera di gruppo
Un incontro collettivo gratuito pensato per persone che condividono una situazione lavorativa simile alla tua. Un’occasione per confrontarsi, fare domande e acquisire maggiore consapevolezza sui principali aspetti della previdenza.
- Elsa Premium Smart
Una consulenza personalizzata di un’ora per analizzare la tua posizione previdenziale in modo dettagliato. Riceverai risposte su fondi pensione, contributi e strategie di accumulo, con informazioni studiate appositamente sulle tue esigenze.


