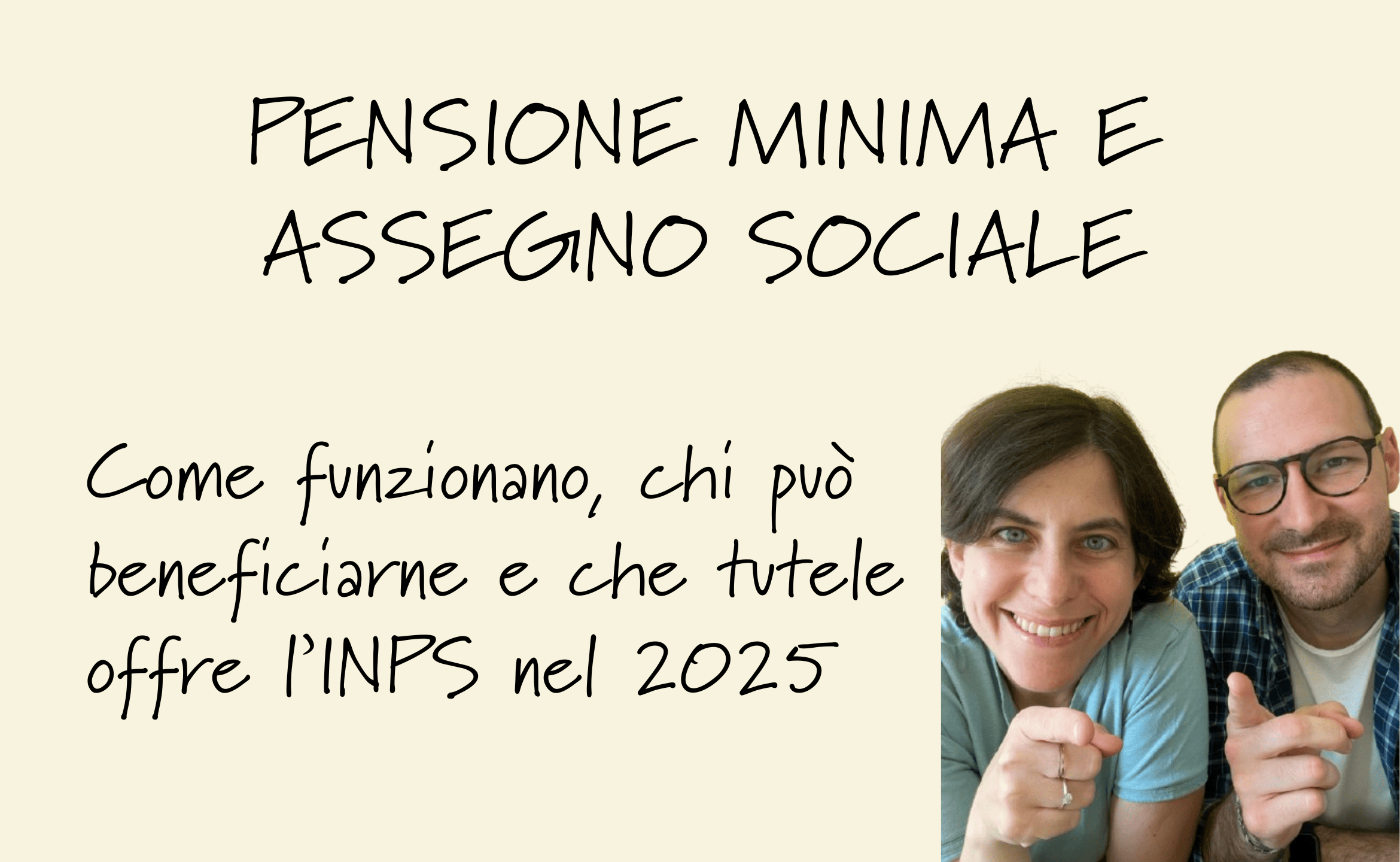
L’approfondimento di oggi affronta un tema che, per molti, si presenta come un vero e proprio labirinto normativo: cosa accade se la pensione maturata non basta a garantire una vita dignitosa?
Termini come “integrazione al minimo” e “assegno sociale” sono spesso tirati in ballo, ma non sempre è chiaro di cosa si tratti e quali siano le differenze tra i due strumenti.
Si tratta, in realtà, di misure diverse ma accomunate da una stessa finalità: essere una “rete di protezione” per chi, in età avanzata, rischia di trovarsi con un reddito insufficiente. È l’impegno dello Stato per evitare condizioni di povertà o difficoltà economiche gravi.
Nel corso di questo articolo analizzeremo i criteri di accesso, le regole e le modalità di erogazione, così da fare chiarezza su come funzionano queste tutele.
Pensione minima? Facciamo chiarezza
Per essere rigorosi, più che di “pensione minima” è corretto parlare di integrazione al trattamento minimo. Con questa espressione si indica la possibilità per l’INPS di riconoscere un incremento a una pensione già esistente, quando l’importo della pensione erogata risulta inferiore alla soglia minima fissata dalla legge.
Non si tratta dunque di una prestazione autonoma, ma di un vero e proprio “adeguamento verso l’alto” di una pensione esistente. La logica è semplice: evitare che il pensionato scivoli al di sotto di una soglia considerata insufficiente, garantendo così un livello di vita ritenuto accettabile.
A determinare questa condizione possono concorrere diversi fattori: carriere lavorative frammentate, occupazioni precarie, periodi di disoccupazione o lunghi part-time.
Tutte situazioni che, sommate, producono un versamento di contributi incapace di generare una pensione adeguata a sostenere una vita dignitosa.
Vale la pena anticipare fin da subito un punto importante: per chi rientra nel sistema di calcolo misto, l’integrazione al minimo può effettivamente entrare in gioco e attenuare l’impatto di una pensione troppo bassa. Diversa è invece la situazione per chi ricade interamente nel metodo contributivo, dove questa possibilità non è contemplata. Approfondiremo nel dettaglio questa distinzione nei prossimi paragrafi.
Come funziona la pensione minima?
Quest’anno il trattamento minimo è stato fissato a 603,40 € lordi al mese (pari a 7.844,20 € annui considerando le tredici mensilità), importo rinnovato dall’adeguamento dello 0,8% rispetto al 2024 (Circolare Inps 23/2025).
Oltre all’incremento percentuale indicato, il 2025 porta con sé alcune novità rilevanti: è stato previsto un aumento straordinario, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che porta il trattamento minimo a 616,67 € lordi mensili (8.016,71 € lordi annui).
È bene, però, prestare attenzione a un dettaglio importante: questa rivalutazione straordinaria (+2,2%) viene applicata esclusivamente a chi percepisce già l’integrazione al minimo. Chi invece non ne ha ancora beneficiato, dovrà presentare apposita domanda all’INPS per poter usufruire di tale incremento.
Se le pensioni integrate al trattamento minimo costituiscono l’unico reddito disponibile, rientrano nella cosiddetta “no tax area Irpef”: una soglia di reddito (meno di 8.500 €) entro cui non vi è l’obbligo di pagare l’imposta in quanto le detrazioni fiscali previste cancellano l'imposta dovuta. La “no tax area” non elimina le imposte quindi, ma le azzera tramite detrazioni.
L’integrazione al minimo tuttavia non è una prestazione definitiva, ma una misura di carattere temporaneo, rinnovata di anno in anno con l’obiettivo di preservare il potere d’acquisto dei pensionati.
Per comprendere al meglio il funzionamento della pensione minima, facciamo un esempio e ipotizziamo un pensionato che ha maturato una pensione di 500 € mensili (6.500 € annui). In questo caso, oggi l’INPS corrisponde al soggetto un'integrazione di 116,67 € al mese così da poter portare il valore complessivo della pensione a 616,67 €, il limite minimo previsto dalla legge.
Chi può fare domanda per l’integrazione al trattamento minimo?
L’integrazione al minimo non è riconosciuta automaticamente a tutti. Possono beneficiarne solo le persone che soddisfano determinate condizioni:
- essere titolari di una pensione diretta (vecchiaia) oppure indiretta (reversibilità), calcolata con il sistema retributivo o misto;
- risiedere in Italia;
- percepire redditi personali o, se coniugati, anche familiari, entro i limiti previsti dalla legge. Nello specifico,
- se il pensionato vive da solo, il reddito personale annuo non deve superare 8.016,71 €, corrispondenti, appunto, a 616,67 € mensili
- se è coniugato, il reddito complessivo della coppia non deve eccedere 31.376,80 €.
La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, non è necessario inviare una domanda specifica: l'integrazione al trattamento minimo viene quasi sempre riconosciuta d'ufficio dall'INPS nel momento in cui la pensione “base” viene liquidata.
Questo accade perché, quando si presenta la domanda di pensione, l'INPS raccoglie già tutte le informazioni necessarie, inclusi i dati reddituali (comunicati nel modulo di richiesta). Se dai calcoli risulta che la tua pensione sarebbe troppo bassa e rispetti i limiti di reddito, l'integrazione viene applicata automaticamente.
Tuttavia, ci sono alcune situazioni in cui potrebbe essere necessario un intervento da parte tua:
- Variazioni reddituali: se dopo il riconoscimento della pensione e dell'integrazione i tuoi redditi (o quelli del tuo coniuge) subiscono variazioni significative (ad esempio, inizi a percepire un nuovo reddito, o viceversa, lo perdi), devi comunicarlo all'INPS. Questo perché l'integrazione al minimo è agganciata al requisito "reddituale", e il diritto può variare di anno in anno in base alle tue entrate.
- Richieste pregresse: in alcuni casi, se l'integrazione non è stata applicata in passato per un errore o una mancanza di dati, potresti dover presentare una domanda di "ricostituzione della pensione per motivi reddituali".
- Aggiornamenti annuali: ogni anno, è fondamentale presentare all'INPS la dichiarazione dei redditi (o il modello RED, se richiesto), anche se non si è obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate. È proprio attraverso questi dati che l'INPS verifica la sussistenza dei requisiti reddituali per l'integrazione.
Lavoratori “post 1996”: esclusi dalla pensione minima
Tra le condizioni che abbiamo citato poco fa per ottenere la “pensione minima”, abbiamo appositamente fatto riferimento alle pensioni dirette oppure indirette, calcolate con il sistema retributivo o misto.
Questo perché, in generale, non hanno diritto all’integrazione al minimo i pensionati il cui trattamento è calcolato interamente con il sistema contributivo, ossia coloro che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996.
Questa esclusione deriva da un meccanismo intrinseco al calcolo delle pensioni. Per ottenere la pensione di vecchiaia, attualmente sono richiesti i seguenti requisiti:
- Età minima: 67 anni (soggetta ad adeguamento in base all’aumento della speranza di vita)
- Anzianità contributiva: almeno 20 anni di contribuzione (corrispondenti a 1.040 settimane di contributi).
Per chi rientra nel sistema misto, il raggiungimento di questi criteri garantisce automaticamente l’accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dall’importo della pensione, con eventuale integrazione al minimo.
Per i “contributivi puri”, invece, è necessario un terzo requisito:
- Importo della pensione lorda deve essere almeno pari al valore dell’assegno sociale che quest’anno è di 7.002,84 € all’anno (538,68 € al mese). Fino a fine 2023, tale limitazione era più elevata, pari all'1,5% del valore dell’assegno sociale.
Di conseguenza, i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dopo il 1996, non possono accedere alla pensione di vecchiaia se non sono stati versati contributi sufficienti a garantire una pensione lorda annua almeno pari a questo importo.
Per arrivare a una pensione di questo livello occorre, oggi, un montante contributivo leggermente superiore a 100.000 €, il che corrisponde, lungo l’arco della vita lavorativa, a redditi annui inferiori a 10.000 € lordi all’anno in media in 40 anni di lavoro.
Se non si raggiunge tale livello minimo di pensione, il soggetto dovrà attendere di maturare i requisiti per la pensione di Vecchiaia Contributiva, cioè aver:
- compiuto 71 anni;
- almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Se la tua pensione non può essere integrata al minimo perché rientra interamente nel sistema contributivo, oggi ci sono comunque altre forme di sostegno a cui puoi accedere.
Tra le principali:
- Maggiorazioni sociali: consistono in un aumento dell’importo delle pensioni, sia di tipo previdenziale che assistenziale, riconosciuto a persone in condizioni economiche svantaggiate che abbiano compiuto almeno 70 anni di età.
- Assegno sociale: riconosciuto, su richiesta, a chi ha almeno 67 anni e rientra nei limiti di reddito stabiliti dalla legge: ne parliamo approfonditamente nel prossimo paragrafo.
- Rendita integrativa dal fondo pensione: prestazione erogata al momento del pensionamento, sotto forma di rendita vitalizia. Non si tratta di un aiuto assistenziale, ma del risultato di un percorso di risparmio e dei relativi rendimenti maturati nel tempo. L’importo dipende dalle somme accumulate e dalle modalità di erogazione scelte, rappresentando così un’integrazione stabile alla pensione pubblica, particolarmente utile nei casi in cui non sia prevista l’integrazione al minimo.
La possibilità offerta dalla previdenza complementare
Segnaliamo inoltre che la legge di Bilancio del 2025 ha introdotto un’interessante novità: da quest’anno sarà possibile utilizzare il fondo pensione anche per raggiungere le “soglie minime” previste del sistema contributivo, necessarie per accedere alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata contributiva.
In pratica, per esempio, se a 67 anni il montante contributivo accumulato presso l’INPS genera un assegno più basso dell’importo minimo, sarà possibile aggiungere anche la rendita vitalizia del proprio fondo pensione senza dover, a parità di contributi, per forza attendere il compimento dei 71 anni.
Abbiamo spiegato tutto nel nostro articolo dedicato per capire meglio l’impatto dell’ultima Manovra sulle pensioni anticipate.
Assegno sociale: cos’è e come funziona
L’Assegno sociale è una prestazione economica a carattere assistenziale, erogata su domanda ai cittadini italiani e stranieri che si trovano in condizioni economiche disagiate, con redditi al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Introdotto il 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale, questo beneficio:
- non è reversibile ai familiari superstiti
- non è soggetto a pignoramenti, sequestri, cessioni o esportazione all’estero.
Per il 2025, l’importo è di 538,69 € per 13 mensilità. Per ottenere l'assegno sociale, è necessario rispettare specifici criteri:
- almeno 67 anni di età;
- cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
- residenza effettiva in Italia;
- requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 2009);
- trovarsi in uno stato di bisogno economico con specifici limiti di reddito.
Con riferimento all’ultimo punto, l’assegno sociale viene riconosciuto per intero quando:
- il richiedente non è sposato e non ha alcun reddito;
- il richiedente è coniugato e il reddito della coppia non supera 7.002,97 € l’anno.
Oppure si prevede un importo ridotto se:
- il richiedente non coniugato percepisce un reddito annuo comunque inferiore a 7.002,97 €;
- il richiedente sposato ha un reddito familiare compreso tra 7.002,97 € e 14.005,94 € annui.
L’Assegno sociale, rimanendo al di sotto della cosiddetta “no tax area”, non è soggetto a trattenute IRPEF.
Per richiedere l’assegno sociale è necessario presentare la domanda online all’INPS tramite il servizio dedicato. In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center, oppure a un patronato o a intermediari autorizzati, che provvedono all’invio telematico dell’istanza
Conclusioni
La pensione minima e l’assegno sociale sono strumenti fondamentali di protezione, pensati per garantire un sostegno economico a chi, a causa di carriere frammentate o redditi troppo bassi, rischierebbe di gestire la vecchiaia con redditi insufficienti.
Sapere che esiste un “paracadute” può certamente offrire un po’ di tranquillità, ma bisogna essere consapevoli che si tratta di misure assistenziali, con importi contenuti e requisiti stringenti, che garantiscono solo un livello minimo di sussistenza.
Per questo, se si ha tempo davanti a sé, è importante valutare soluzioni che vadano oltre la sola previdenza pubblica. Costruire un secondo o terzo pilastro pensionistico attraverso un fondo pensione significa integrare in modo stabile e programmato la pensione di domani, evitando di dover dipendere esclusivamente da strumenti di natura assistenziale.
La pianificazione previdenziale è una scelta consapevole, che richiede valutazioni attente sulle proprie esigenze personali e familiari. Per accompagnarti in questo percorso, mettiamo a disposizione due servizi dedicati:
- Elsa Premium Smart: hai domande su fondi pensione e TFR? Con un’ora di consulenza personalizzata, costruiremo insieme una strategia previdenziale su misura, pensata per garantirti serenità e stabilità quando arriverà il momento del pensionamento.
- Elsa Premium 360: vuoi sapere quanti contributi hai accumulato tra INPS, casse previdenziali o all’estero? Vuoi chiarire ogni dubbio per andare in pensione prima e con più sicurezza economica? Con Elsa Premium 360 puoi avere una visione completa della tua posizione previdenziale e delle strategie migliori per ottimizzarla.


