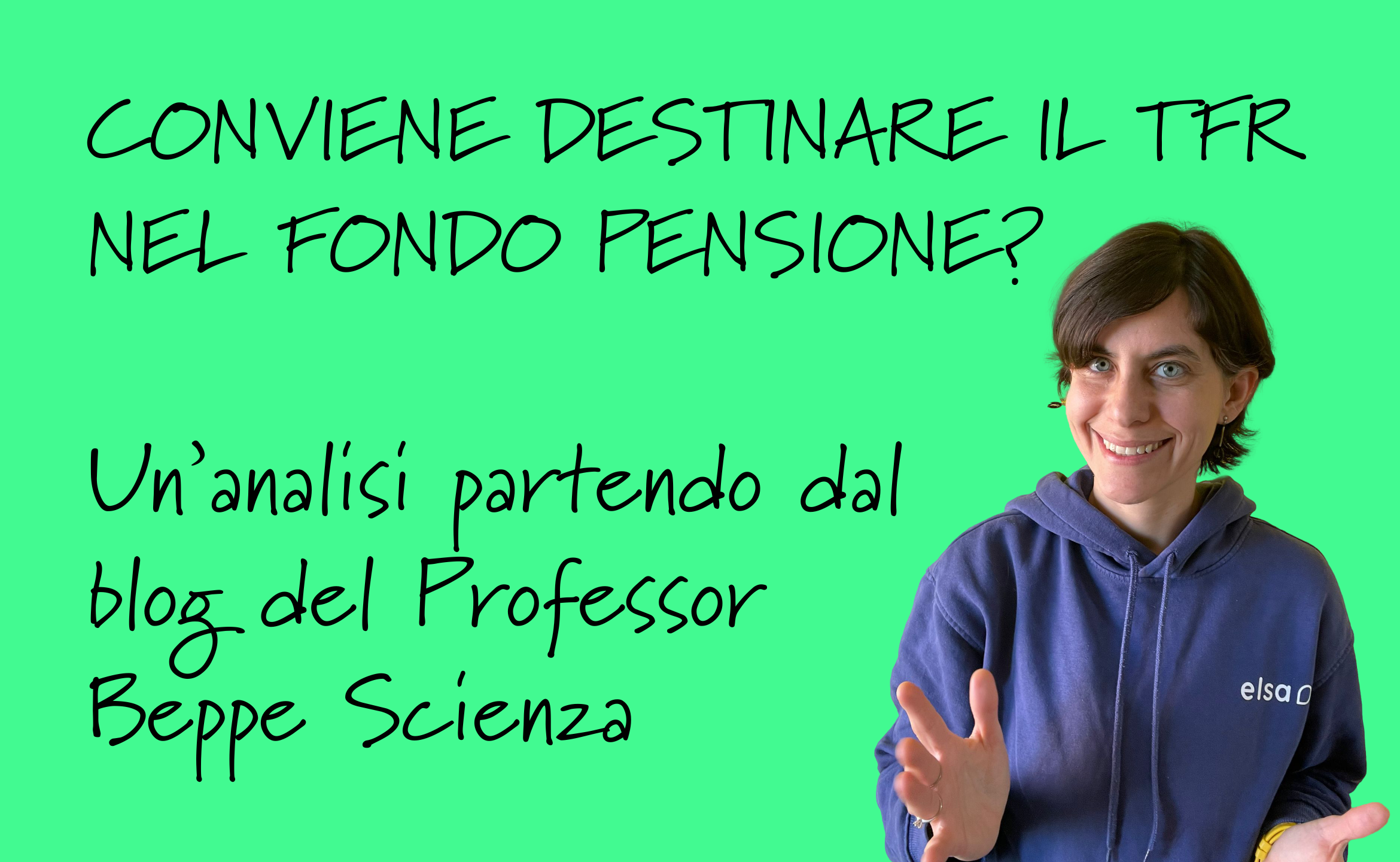
Abbiamo letto con interesse e un pizzico di sorpresa l’intervista del giornale online Open al Professor Beppe Scienza in cui il Professore stesso ha parlato delle conclusioni riportate nell’articolo dal titolo “Fondi pensione. Ecco perché gli sbandierati vantaggi fiscali non reggono alla prova dei numeri”.
Lo studio condotto dal Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino, guidato dallo stesso autore, arriva a una conclusione netta: i benefici fiscali della previdenza complementare sarebbero sopravvalutati, spesso utilizzati come leva commerciale per convincere i lavoratori ad aderire a fondi pensione costosi e poco vantaggiosi.
Ma è davvero così?
Oppure c’è dell’altro da considerare?
Per rispondere, analizziamo in modo semplice ma rigoroso come viene tassato il TFR, sia se lasciato in azienda sia se destinato alla previdenza complementare.
TFR e tassazione: come si calcola il netto? Differenza tra fondo pensione e azienda
Da oltre un ventennio, un lavoratore può scegliere se lasciare il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria Inps) o destinarlo a un fondo pensione.
A seconda della scelta, cambia il trattamento fiscale in modo sostanziale.
- Se destinato a un fondo pensione: il TFR viene tassato al momento del pensionamento con un’aliquota agevolata pari al 15% nei primi quindici anni di adesione e che si riduce poi dello 0,3% per ogni anno di permanenza oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9% che si ottiene dopo 35 anni di adesione.
Immaginiamo quindi l’esempio di un dipendente, Mario Rossi, che ha lavorato per 20 anni presso la stessa azienda e ha destinato il proprio TFR alla previdenza complementare.
Per semplicità ipotizziamo che nel periodo non abbia beneficiato di aumenti contrattuali. La sua retribuzione annua lorda è di 20.000 €.
Ogni anno, il TFR maturato è calcolato dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5.
Per Mario, questo significa:
TFR annuo = 20.000 € / 13,5 = 1.481,50 €
In 20 anni, senza considerare i rendimenti maturati dal fondo pensione, il TFR totale maturato sarà:
TFR totale = 1.481,50 € x 20 = 29.630 €
La tassazione finale sarà pari a 13,5% [15% - 0,3% x 5 (anni in più rispetto al 15esimo)].
Il TFR netto corrisponderà a 25.630 €, per un totale di imposte pagate pari a 4.000 €.
- Se lasciato in azienda: il TFR viene tassato con un meccanismo più complesso, basato sull’aliquota media IRPEF degli ultimi cinque anni.
Stesso esempio: immaginiamo, infatti, che Mario Rossi non si sia iscritto al fondo pensione e abbia lasciato il TFR in azienda per lo stesso periodo di tempo (20 anni).
TFR totale (in azienda) = 1.481,50 € x 20 = 29.630 €
Una volta determinato l’ammontare del TFR (anche qui per semplicità, non teniamo in considerazione la rivalutazione), per conoscere l’importo netto è necessario calcolare innanzitutto il “reddito di riferimento” che si ottiene moltiplicando il TFR maturato per il numero fisso 12 e dividendo la cifra per gli anni di servizio.
Nel nostro esempio, il reddito di riferimento sarà (29.630 € x 12) : 20 = 17.778 €.
Questa cifra rappresenta la base imponibile, a cui vanno applicate le aliquote IRPEF, che dipendono dagli scaglioni IRPEF stessi.
Applicheremo quindi un’aliquota del 23% su 17.778 €, ottenendo così una cifra di 4.089 €.
E’ ora arrivato il momento di ottenere l’aliquota media.
Il calcolo sarà:
(4.089 € : 17.778 €) x 100 = 23%.
Questa è l’aliquota che dovremo applicare al TFR lordo per conoscere l’entità della tassazione (che nel nostro caso è di 6.815 €).
Il TFR netto è dunque pari a 22.815 €.
Tale imposta deve però essere verificata dall’Agenzia delle Entrate, che deve assicurarsi che l’imposta sia liquidata in base all’aliquota media di tassazione non dell’ultimo anno di servizio, ma dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.
Il vantaggio fiscale dei fondi pensione esiste davvero?
Confrontando i due scenari dell’esempio, il risparmio fiscale per Mario è di 2.815 € a favore del fondo pensione.
E questo senza considerare eventuali rendimenti del fondo, contributi del datore di lavoro o deduzioni fiscali aggiuntive.
Sul fronte dei rendimenti, il Professor Beppe Scienza sottolinea giustamente come la “redditività degli investimenti” sia aleatoria.
La stessa Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) avverte che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e che i costi applicati, soprattutto nel lungo periodo, possono incidere sul risultato finale.
È un’osservazione condivisibile, ma ciò non smentisce l’esistenza di un vantaggio fiscale strutturale, che aumenta al crescere:
- del reddito del lavoratore;
- dei versamenti volontari (che sono deducibili dal reddito imponibile);
- dell’eventuale contributo aggiuntivo dell’azienda, spesso previsto nei contratti collettivi;
- della possibilità di destinare il welfare aziendale deducibile e il premio di risultato con esenzione fiscale.
Rivalutazione TFR e rendimenti finanziari: le differenze
Il TFR accantonato e lasciato in azienda si rivaluta ogni anno secondo un meccanismo stabilito per legge:
- quota fissa pari al 1,5% annuo;
- quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Questa formula garantisce una rivalutazione legata all’inflazione, ma generalmente con un rendimento modesto.
In periodi di bassa inflazione, il rendimento effettivo può essere inferiore al 2% annuo lordo.
Chi decide di accantonare il TFR in azienda non ha margini di scelta: anche su orizzonti temporali lunghi, la rivalutazione è sempre legata all’andamento dell’inflazione.
Invece, i fondi pensione investono le risorse nei mercati finanziari (obbligazioni, azioni, ecc.), con l’obiettivo di farle crescere nel tempo.
I rendimenti sono quindi per loro natura variabili, potenzialmente più elevati nel lungo periodo, specie nei comparti con maggiore esposizione azionaria, diversificati per profilo di rischio, grazie alla possibilità di scegliere comparti più o meno prudenti.
E’ infatti bene ricordare che la scelta dell’investimento dovrebbe basarsi su:
- orizzonte temporale; in un fondo pensione dovrebbe corrispondere agli anni mancanti al pensionamento
- propensione al rischio; rappresenta il livello di incertezza che una persona è disposta a tollerare nelle proprie decisioni finanziarie, ovvero quanto un investitore è disposto a tollerare volatilità in cambio della possibilità di ottenere rendimenti futuri potenzialmente più elevati
Ad esempio, un lavoratore vicino al pensionamento potrebbe orientarsi verso un comparto garantito o obbligazionario, che, pur offrendo rendimenti più contenuti, presenta una minore volatilità nel breve periodo, ottimizzando al contempo il vantaggio fiscale sul TFR.
Differentemente, un giovane che si affaccia al mondo del lavoro potrebbe considerare una linea bilanciata o azionaria, che comporta una maggiore incertezza nel breve termine, ma mira a rendimenti potenzialmente più elevati nel medio-lungo periodo in grado di compensare i costi fissi.
I dati Covip dimostrano come il fattore tempo sia un alleato prezioso: più lungo è l’orizzonte temporale, maggiore è la possibilità di capitalizzare i rendimenti e di gestire efficacemente le oscillazioni di mercato.
Ridurre progressivamente nel tempo l’esposizione azionaria, orientandosi prima verso comparti bilanciati, poi obbligazionari e infine garantiti, rappresenta una strategia efficace per consolidare i risultati ottenuti nel medio-lungo periodo e proseguire, negli anni immediatamente precedenti il traguardo pensionistico, all’interno di soluzioni caratterizzate da un livello di rischio più contenuto.
In un confronto realmente equilibrato, il rapporto tra i rendimenti finanziari dei fondi pensione e la rivalutazione del TFR in azienda dovrebbe quindi essere valutato considerando lo stesso orizzonte temporale e tenendo conto delle differenti caratteristiche dei potenziali aderenti.
Non è corretto, infatti, limitare l’analisi ai periodi caratterizzati da performance finanziarie particolarmente positive (o negative), così come risulterebbe altrettanto scorretto basare il confronto su fasi storiche in cui l’inflazione è stata eccezionalmente alta, come accaduto nel periodo 2022-2023, andando così a enfatizzare artificiosamente la rivalutazione del TFR lasciato in azienda, sulla base di episodi eccezionali.
Costi e “irrevocabilità” dei fondi pensione: sono comunque convenienti?
Al centro della critica del Professor Beppe Scienza si colloca poi il tema dei costi applicati dai fondi pensione che nel tempo andrebbero a “erodere” i vantaggi fiscali maturati dal lavoratore, aggravando il tutto con quella che definisce una presunta “irrevocabilità” della scelta previdenziale.
Partiamo dalla prima critica: i costi.
Tutti i fondi pensione applicano dei costi, ma la loro entità cambia molto da un fondo pensione all'altro.
Come ricordato dallo stesso Professore, la COVIP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, mette a disposizione sul proprio sito il calcolo dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo), che calcola l'impatto dei costi applicati dal fondo in quattro orizzonti temporali: 2, 5, 10 e 35 anni.
L'ISC viene calcolato dalla COVIP per ogni linea d'investimento di ogni fondo pensione considerando un versamento annuo di 2.500 € e un rendimento netto ipotetico del 4%.
Queste due costanti nella vita reale non esistono, infatti, sono da intendersi come due variabili.
Se ti interessa capire quale fondo pensione potrebbe essere più adatto a te e vuoi effettuare una comparazione che analizza il tuo caso specifico a partire dai tuoi dati, puoi usare il Comparatore di Fondi Pensione di Ciao Elsa.
Per quanto riguarda la seconda critica, ovvero l'irrevocabilità della scelta previdenziale, è opportuno fare maggiore chiarezza.
La scelta di destinare il proprio TFR alla previdenza complementare rappresenta formalmente una scelta irreversibile: il lavoratore, una volta che ha optato per versare il TFR maturando in un fondo pensione, non può cambiare idea e lasciarlo successivamente in azienda.
Attenzione però: ci sono dei casi previsti dalla normativa, come la perdita del lavoro o il cambio di CCNL, in cui è prevista la possibilità di riscattare il proprio fondo pensione con il TFR e ripartire da zero con la scelta della destinazione futura.
Nel caso in cui, invece, un aderente volesse cambiare fondo pensione, magari perché ne trova uno più adeguato alle sue esigenze o con costi significativamente più bassi rispetto a quello che aveva scelto inizialmente, il d.Lgs 252/2005, che regolamenta la previdenza complementare italiana, garantisce la possibilità di trasferire il proprio fondo pensione in qualunque altro fondo pensione dopo soli due anni dall'apertura e se si ha un fondo di categoria anche prima dei due anni se si cambia settore professionale.
Quindi è sempre possibile cambiare e optare per un fondo che sia più conveniente o che si ritiene più adatto alla propria situazione.
Anche per quanto riguarda i versamenti volontari che godono del vantaggio della deduzione fiscale, si può sempre decidere di cambiare fondo, modificare la quota annuale versata e anche azzerarla senza che ci siano vincoli, obblighi di versamento o penali di alcun tipo.
Se è vero che i fondi pensione per loro natura sono pensati per esserci di aiuto una volta arrivati in pensione, è altrettanto vero che sono gestibili e flessibili in fase di versamento volontario e di scelta e cambiamento dell'investimento e del fondo stesso.
La previdenza complementare può essere conveniente se si sa cos’è e come funziona
Lo studio citato offre spunti di confronto e una lettura critica che tuttavia non deve portare a generalizzazioni.
I numeri che abbiamo condiviso in questo articolo, se letti nel loro complesso, confermano che un vantaggio fiscale c’è. E può essere significativo, specie se integrato da ulteriori benefici come deduzioni e contributi aziendali.
Per questo, riteniamo che la previdenza complementare non sia una favola, ma uno strumento di pianificazione che, se ben utilizzato, può fare la differenza.
Come sempre, la chiave è l’informazione: sapere cosa si sta sottoscrivendo, con quali costi e in quale orizzonte temporale.
Per questo noi Ciao Elsa pubblichiamo contenuti approfonditi legati a questi temi sul nostro blog, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Instagram, oltre ad organizzare ogni settimana webinar di formazione gratuiti sulla previdenza complementare per i dipendenti del settore privato, i dipendenti pubblici e i liberi professionisti e autonomi.
Conoscenza e consapevolezza sono i migliori alleati contro l’incertezza: informarsi è sempre il punto di partenza più sicuro.


