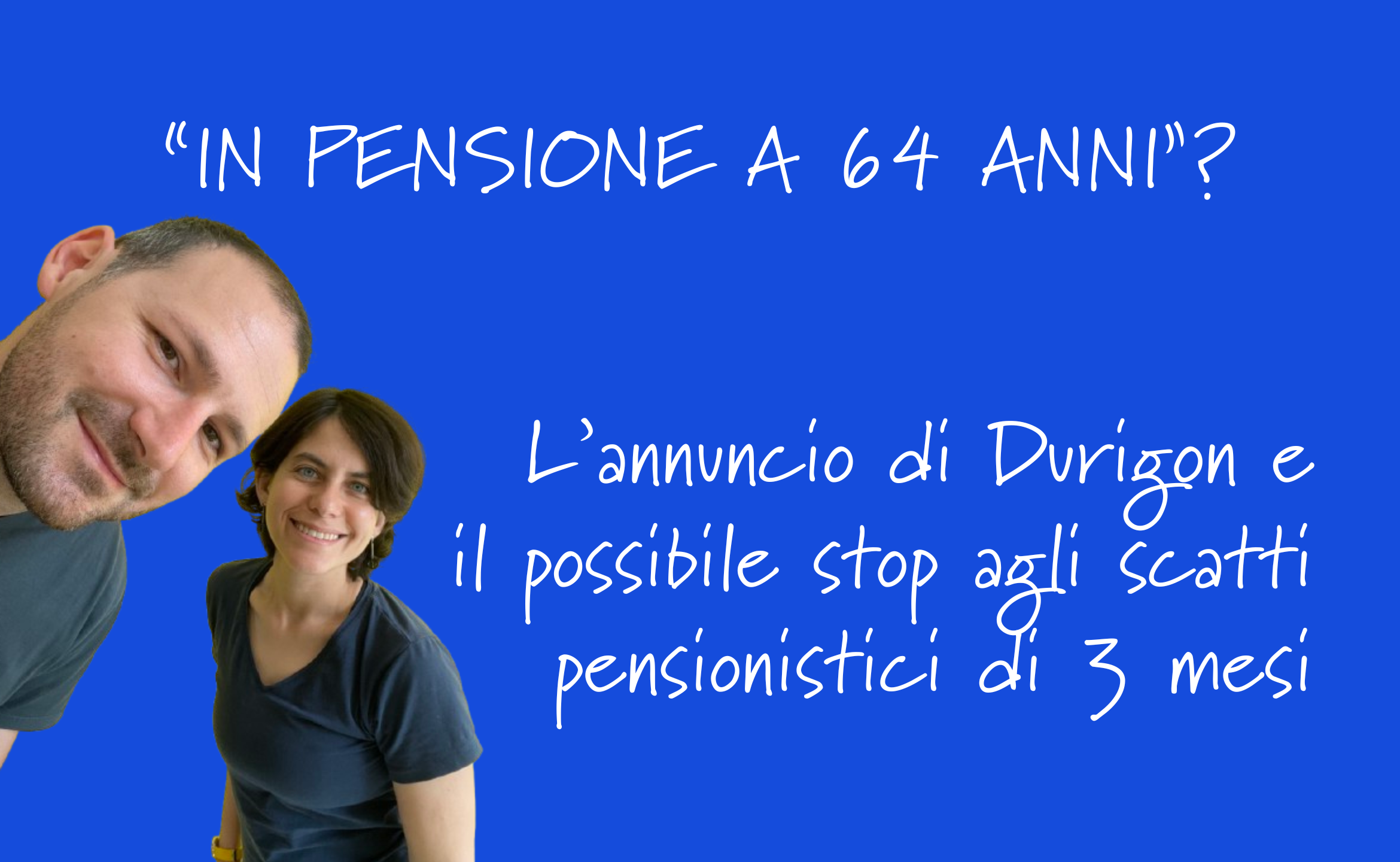
L’estate si avvia verso un finale caldo, non solo per le temperature.
Si prepara infatti a riaccendersi il dibattito su un tema che non smette mai di catalizzare l’attenzione: le pensioni.
Al centro della scena, un piccolo ma significativo scontro “contabile” tra INPS e Ragioneria dello Stato relativamente ai costi legati alla sospensione dell’adeguamento automatico dei requisiti di accesso al pensionamento in relazione all’allungamento dell’aspettativa di vita certificato dall’Istat.
Dietro questa questione si cela una forte valenza politica.
Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro con delega alla previdenza, ha già annunciato, in accordo con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, l’intenzione di “sterilizzare” questo aumento almeno per il biennio 2027-2028.
Ma cosa succederà dopo?
Proviamo a fare chiarezza su una situazione che rischia di influenzare profondamente il sistema pensionistico italiano.
Requisiti pensionistici e aspettativa di vita
A partire dal 1° gennaio 2027, salvo modifiche nella prossima legge di bilancio, i lavoratori italiani dovranno fare i conti con uno slittamento dei requisiti per la pensione.
Le finestre di uscita interessate sono principalmente due.
1- Pensione di vecchiaia che attualmente richiede:
- almeno 67 anni di età
- un minimo di 20 anni di contributi
2- Pensione anticipata, basata unicamente sugli anni di contribuzione maturati, oggi pari a:
- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne
Con lo slittamento previsto dal meccanismo di adeguamento alla speranza di vita Istat, dal 2027 i requisiti diventerebbero:
- Pensione di vecchiaia: 67 anni e 3 mesi di età (confermati i 20 anni minimi di contributi).
- Pensione anticipata:
- 43 anni e 1 mese di contributi per gli uomini
- 42 anni e 1 mese di contributi per le donne
L’aumento non è frutto di una scelta politica contingente, ma del meccanismo automatico di adeguamento alla speranza di vita, introdotto in Italia oltre dieci anni fa per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale a ripartizione.
Ogni due anni, l’Istat rileva la variazione della speranza di vita a 65 anni, prendendo tale parametro come indicatore dell’aspettativa di vita dopo il pensionamento.
Se l’indicatore cresce, anche i requisiti di uscita dal lavoro vengono aggiornati in proporzione ogni due anni.
Perché?
Il meccanismo di adeguamento automatico è stato introdotto per rispondere a una tendenza di fondo: l’allungamento della vita media.
Negli ultimi decenni, la speranza di vita in Italia è cresciuta di diversi anni, e questo, in un sistema a ripartizione, significa che ogni generazione percepisce la pensione per un periodo più lungo rispetto a quella precedente.
Per evitare che questo comporti un peso eccessivo per i conti pubblici, la normativa prevede di “spalmare” parte di questa maggiore longevità nella vita lavorativa. Un criterio che dovrebbe garantire equità intergenerazionale e sostenibilità finanziaria.
Senza correttivi, questo fenomeno potrebbe generare squilibri strutturali: i contributi versati dai lavoratori attivi potrebbero non essere sufficienti a coprire le pensioni erogate, e lo Stato dovrebbe intervenire con risorse aggiuntive, aumentando il debito o la pressione fiscale.
L’adeguamento automatico consente di mantenere in equilibrio il rapporto tra vita lavorativa e periodo di pensionamento, senza dover intervenire ogni volta con riforme ad hoc.
Un meccanismo che solleva scontri, anche sulle cifre
Se il principio è chiaro, l’applicazione è da sempre oggetto di contestazioni. Negli ultimi anni, in più di un’occasione, governi di diverso colore politico hanno deciso di sospendere temporaneamente gli aumenti legati alla speranza di vita.
E l’attuale esecutivo sembra non volersi esentare: già all’indomani della denuncia della Cgil, che a gennaio 2025 aveva segnalato che l’INPS aveva inserito nei propri database i nuovi requisiti pensionistici prima ancora che fossero ufficializzati dall’Istat, salvo poi tornare sui propri passi, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti aveva dichiarato l’intenzione di “sterilizzare” l’aumento.
Lo afferma anche il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, che, in una recente intervista, ha confermato l’intenzione di bloccare per il biennio 2027-2028 l’adeguamento di tre mesi, lanciando l’ipotesi di un intervento strutturale nel 2029, data però successiva alle elezioni governative.
Nel frattempo, se la volontà politica è chiara, molto meno puntuale è la quantificazione del costo.
L’INPS stima che bloccare oggi i tre mesi di aumento costerebbe tra 3 e 3,5 miliardi di euro. La Ragioneria generale dello Stato offre invece una valutazione decisamente più contenuta: 300 - 400 milioni di euro.
Le cifre in gioco potrebbero poi variare in funzione della platea di riferimento: la “sterilizzazione” potrebbe infatti essere integrale e riguardare tutta la platea dei lavoratori oppure essere mirato a specifiche categorie, come i circa 44.000 lavoratori “esodati” che hanno già sottoscritto accordi di uscita anticipata con le aziende e che rischiano, dal 2027, di restare senza reddito per tre mesi.
Le cifre in gioco potrebbero ovviamente avere conseguenze politiche e di bilancio rilevanti.
Se dovessero prevalere le stime INPS, reperire oltre 3 miliardi in un contesto di vincoli di finanza pubblica sarebbe complesso. Per questo, una delle soluzioni allo studio della Ragioneria sarebbe finanziare con la prossima legge di bilancio soltanto il primo anno del biennio di incremento, rinviando all’anno successivo la copertura finale del periodo.
Gli effetti di una sterilizzazione temporanea
Bloccare ora l’aumento del 2027 ha un effetto collaterale di cui però si parla poco: il rischio di un “effetto scalino” nel 2029.
Infatti, se nel 2027 i tre mesi aggiuntivi verranno congelati, due anni dopo scatterebbe il nuovo adeguamento alla speranza di vita, che già oggi l’Istat prevede in ulteriori tre mesi.
Risultato: un aumento improvviso di sei mesi in un solo anno.
Questo tipo di discontinuità potrebbe rappresentare un problema non solo per i lavoratori, che si troverebbero a ricalcolare improvvisamente il proprio percorso di uscita, ma anche per l’INPS e le aziende.
L’INPS, in questo contesto, ha infatti un’esigenza primaria: disporre di regole chiare e definitive per poter aggiornare i propri database e fornire indicazioni certe a imprese e sindacati.
Dall’altra parte, le aziende che hanno in corso piani di esodo incentivato o accordi di prepensionamento devono sapere con precisione quali saranno i requisiti, per evitare di trovarsi con lavoratori che restano “a metà del guado” tra fine del lavoro e inizio della pensione.
Il pasticcio dello scorso gennaio, quando l’INPS aggiornò i requisiti in base a dati non ancora ufficializzati dall’Istat, è un monito.
Senza chiarezza, il rischio è quello di compromettere la credibilità dell’istituto e creare incertezza nei rapporti industriali e con i cittadini.
La questione è resa ancora più complessa da un vincolo legale: il decreto interministeriale che recepisce i dati Istat e aggiorna i requisiti pensionistici deve essere emanato entro la fine del 2025.
Ciò significa che, anche se il Governo ha intenzione di bloccare l’aumento, dovrà formalmente certificare l’adeguamento previsto.
Durigon: verso un modello senza “Quote”
“Credo che 64 anni possono diventare la vera soglia di libertà pensionistica”.
Con queste parole, il sottosegretario Claudio Durigon si è espresso a chi gli chiedeva se si stesse valutando di estendere anche ai lavoratori nel sistema “misto” la finestra d’uscita anticipata contributiva.
Nel 2025, l’accesso alla pensione anticipata contributiva è possibile solo se vengono rispettati contemporaneamente quattro requisiti:
- Età anagrafica: aver compiuto almeno 64 anni
- Anzianità contributiva: disporre di almeno 20 anni di contributi versati e accreditati
- Importo minimo dell’assegno: la pensione maturata deve essere pari o superiore a tre volte l’assegno sociale. Poiché nel 2025 l’assegno sociale è di 7.002,84 euro lordi annui, la soglia minima da raggiungere è di 21.008,52 euro lordi all’anno
- Regime previdenziale: appartenere interamente al sistema di calcolo contributivo e, quindi, non avere un solo giorno di contributi versati nella previdenza obbligatoria prima del 1996
Attualmente, quindi, tale possibilità è riservata ai “contributivi puri”, ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996.
Non è ancora chiaro se tra le opzioni allo studio del governo rientri un’estensione di tale finestra a tutti i lavoratori “misti”, con o senza vincoli specifici come, ad esempio, il passaggio dell’intero calcolo pensionistico al metodo contributivo, come già avvenuto quest’anno per la cosiddetta “Quota 103”.
Il sistema delle “quote” sembra però essere uscito dalle priorità dell’esecutivo.
Come ha spiegato il Sottosegretario: “Il sistema contributivo ha cambiato tutto: non sempre conviene uscire prima. Le quote non incidono più come un tempo. Il modello su cui vogliamo lavorare è quello già introdotto dell’uscita a 64 anni con 25 anni di contributi, che intendiamo rafforzare”.
Con queste parole, Durigon potrebbe aver “svelato” l’ipotesi sul tavolo: oltre al requisito anagrafico di 64 anni, oggi per accedere alla pensione anticipata contributiva sono richiesti 20 anni di contributi, non 25.
Tale requisito aumenta proprio a 25 anni (fino al 2029, successivamente sale a 30 anni) se per raggiungere la soglia minima di pensione prevista (21.008,52 euro lordi annui) è necessario aggiungere anche la rendita integrativa derivante dal fondo pensione del lavoratore.
Ne abbiamo parlato in modo approfondito nell’articolo dedicato alla pensione anticipata nel 2025, parlando delle novità della Manovra e di come viene impattata la previdenza complementare.
Con questa piccola “rivelazione”, il sottosegretario sembra quindi suggerire che prossimamente potrebbe essere estesa anche ai lavoratori nel regime “misto” la medesima opportunità di combinare previdenza pubblica e privata.
Ti ricordiamo che il sistema misto è previsto per coloro che hanno contributi versati sia prima che dopo il 1996, ovvero la maggior parte dei lavoratori che stanno accedendo alla pensione in questi anni.
Sempre sul tema, il Sottosegretario Durigon ha inoltre evidenziato un obiettivo chiaro: “Vogliamo potenziare la previdenza complementare, anche consentendo di utilizzare il TFR versato all’INPS come rendita integrativa, così da incrementare l’assegno e permettere l’uscita a 64 anni”.
Un’ipotesi che potrebbe prevedere un nuovo “vincolo” sul TFR destinato al Fondo di Tesoreria Inps su cui avevamo già offerto un’analisi approfondita in un nostro precedente articolo.
Il punto di vista di Ciao Elsa
Indipendentemente da quale cifra prevarrà nel confronto tra INPS e Ragioneria Generale sul costo del blocco dell’adeguamento alla speranza di vita, un dato di fondo rimane immutato: nei prossimi decenni l’aspettativa di vita in Italia continuerà a crescere.
È comprensibile che una parte dell’opinione pubblica, e anche del mondo politico e sindacale, percepisca come “iniquo” o addirittura “perverso” il meccanismo automatico di adeguamento, soprattutto per i lavoratori che svolgono mansioni gravose o che hanno iniziato a lavorare in età molto giovane.
Tuttavia, è altrettanto innegabile che, senza un correttivo legato alla longevità, il sistema pensionistico italiano si troverebbe a dover sostenere un onere crescente e difficilmente compatibile con gli equilibri di finanza pubblica: lo Stato potrebbe in tal modo intervenire con misure alternative, come aumenti dei contributi, tagli alle prestazioni o ricorso massiccio alla fiscalità generale.
Non si tratta quindi di una questione puramente tecnica, ma di una scelta strategica che riguarda la sostenibilità a lungo termine del sistema e l’equità intergenerazionale: garantire che le generazioni future possano beneficiare di un trattamento pensionistico proporzionato ai contributi versati, senza scaricare su di esse il peso di decisioni rinviate oggi.
Proprio per questo, il dibattito dovrebbe forse spostarsi dalla contrapposizione “blocco sì – blocco no” verso un’analisi più ampia: come rendere l’adeguamento alla speranza di vita più flessibile e socialmente equo, introducendo correttivi mirati per le categorie più fragili e incentivando strumenti integrativi, come la previdenza complementare, che permettano di anticipare l’uscita senza compromettere la sicurezza finanziaria.
Oggi più che mai è importante conoscere tutte le possibilità a disposizione e fare scelte informate, prima che eventuali cambiamenti limitino la libertà decisionale.
Se vuoi scoprire come funziona il sistema pensionistico italiano e quali vantaggi può offrirti la previdenza complementare, Ciao Elsa ti propone due modalità di supporto e informazione:
- Chiacchiera di gruppo
Un incontro collettivo di un’ora con persone che si trovano in una situazione lavorativa simile alla tua. Un momento di confronto per iniziare a orientarti e acquisire maggiore consapevolezza sui temi previdenziali. - Elsa Premium Smart
Una consulenza personalizzata per approfondire la tua situazione specifica. Rispondiamo ai tuoi dubbi su fondi pensione, contributi, posizione previdenziale, fornendo informazioni studiate su misura per te.


